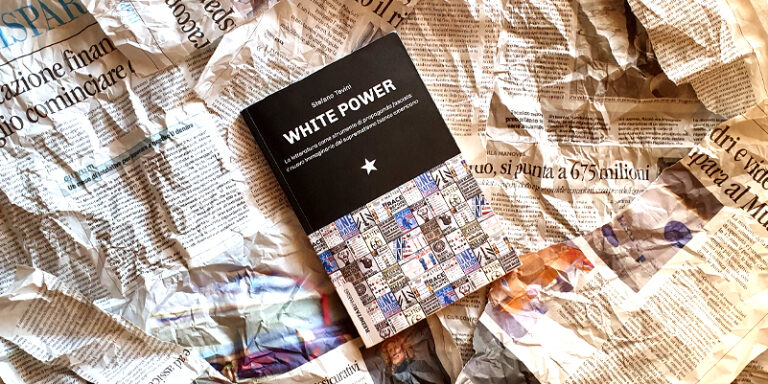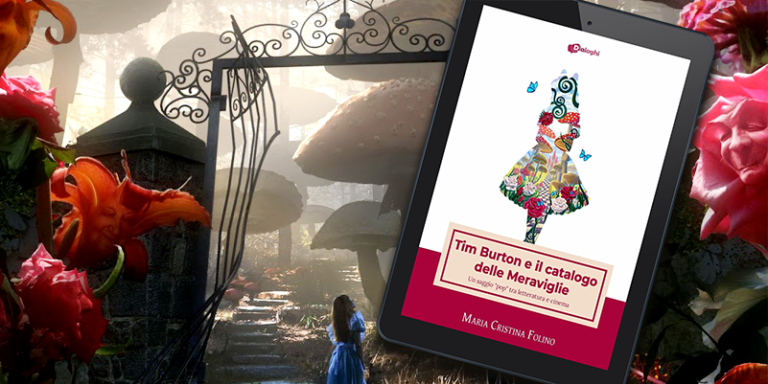Recensione di White Power di Stefano Tevini
Quando ero ancora una sbarbatella e andavo alle superiori, tra le varie strategie comunicativa relative alla storia della pubblicità, arrivammo alla propaganda; rimasi molto impressionata da una tattica che, attraverso strumenti come manifesti e campagne studiate, potesse influenzare il pensiero delle masse.
La storia ci racconta che non è così difficile, lo stesso presente ci mostra come, dall’esposizione di notizie e fatti, si possa modificare la realtà in modo che sia percepita con un messaggio di fondo tale da smuovere la gente verso determinati pensieri politici. Ero un’ingenua quando pensavo che, uno strumento come la pubblicità, potesse essere semplicemente parlare al pubblico condizionandolo a comprare un prodotto. Ormai tutto, anche i social, sono diventati il veicolo di frenesie estreme: dal comprare tutte le novità che escono in libreria, fino a diffondere un determinato pensiero che spinga l’utente medio, accomodato sul proprio divano o sulla tazza del cesso, a porre “pollice verso e pollice recto”.
Quindi forse non dovrei sorprendermi che anche la narrativa potesse divenire uno strumento di propaganda. Invece quando ho scoperto gli studi di Stefano, poi analizzati in questo saggio, sono letteralmente rimasta sbalordita che persino i libri o le storie potessero raccontare (e incitare) l’estrema destra americana. Certo, è frutto di un’ingenuità che vuole le storie come veicoli di morale: cresciamo con le favole della buonanotte che ci trasmettono le regole principali del quieto vivere. Come fai a pensare che le stesse possano sporcarsi, raccontando quanto sia giusto essere bianchi, sottolineando quanto il nemico sia incarnato da ebrei e uomini di razza mista o da nuance di colore, che vanno oltre l’abbronzatura arancio?
Eppure è così, il delirante mondo in cui sono ambientati i romanzi citati da Stefano in White Power ci danno una chiara visione di questo genere, spesso rimasto fuori dal nostro paese, ma che qualcosa ha smosso oltreoceano, visti anche i risultati delle ultime elezioni, o come l’America stia diventando una fabbrica di notizie scritte su misura dei propri interessi.
Leggere resta sempre uno strumento di conoscenza, così come essere consci che ci sono libri che trasmettono morali alterate, mondi che di distopico hanno la visione del nostro mondo pacifico. Soprattutto ora, i libri come questo, ci aiutano a tenere alta la guardia verso un nemico che sa raccontare falsità così reali, da farci credere che siano vere.